A me gli occhi, please! Ti leggerò nel pensiero. E ti dirò cosa vuoi comprare. Brain imaging, biofeedback, eye tracking: sono gli strumenti che permettono agli stregoni del neuromarketing di capire come vendere meglio un prodotto. Una disciplina sempre più diffusa e ormai matura a 15 anni dalla sua definizione. Un po’ di neurologia, un pizzico di psicologia e gli ingredienti sacri del marketing: rientra tutto in questa branca della neuroeconomia che punta ad «analizzare i processi degli individui di fronte a uno stimolo», come la definì Ale Smidts, professore di Marketing Research alla Rotterdam School of Management. Insomma, a leggere la mente delle persone. E nel loro cuore. Perché, come insegna il premio Nobel per l’economia 2017, Richard Thaler, anche nelle decisioni apparentemente più razionali entra in realtà in gioco una forte componente emotiva.
L’incrocio di queste discipline, in apparenza così lontane, permette così di monitorare cosa accade nel cervello delle persone durante l’esperienza d’acquisto, la visione di uno spot o il contatto con un brand. Cosa “si accende” di fronte a un prodotto ben confezionato? E qual è la differenza tra uno spot di successo e uno che passa inosservato? Sono domande a cui da generazioni gli esperti di marketing cercano di dare risposta. Diventa più facile se ci si affida a tecniche d’avanguardia. Tra queste, il brain imaging, cioè la mappatura delle attività cerebrali, perché posso mentire a un sondaggio, ma il nostro cervello non può mentire nelle sue reazioni cognitive- emozionali. C’è poi l’eye tracking, lo studio dei movimenti degli occhi per capire dove cade lo sguardo delle persone o la dilatazione delle pupille per scrutarne le reazioni emotive, oltre a strumenti più comuni come sensori o rilevatori di click. È inoltre possibile utilizzare il Facial Action Coding System che, studiando i movimenti dei muscoli del volto, può leggere cosa ci fa sorridere. Ed è in grado di distinguere tra una reazione autentica e un gesto di circostanza. «Il neuromarketing non manipola. Leggiamo i termometri dell’attività emotiva, non convinciamo i consumatori a fare alcunché», chiarisce subito Luca Florentino, Ceo di Ottosunove, agenzia di marketing e comunicazione che promuove Certamente l’evento italiano più importante sul neuromarketing. «Per far crescere il business devi conoscere il tuo consumatore. Così, da sette anni studiamo il processo decisionale attraverso gli strumenti offerti dalle neuroscienze e applichiamo queste nuove conoscenze per realizzare strategie di comunicazione più efficaci. Nei focus group i clienti possono fornirci molti giudizi razionali, ma poi spesso gli acquisti li fanno “di pancia”».

Per indagare i meandri della mente umana, da una parte Ottosunove ha stretto partnership con università e centri di ricerca, dall’altra si è confrontata con le aziende-clienti scoprendo che questa frontiera era ignota ai più. «Di certo non è un argomento che si studia nelle business school», ammette Florentino. «Ecco come è nata l’idea di un evento pensato per evangelizzare manager e imprenditori e permettere alla business community italiana di capire come utilizzare il neuromarketing. Perché il nostro approccio non è alternativo, ma complementare ai metodi tradizionali di indagine». Un esempio? L’analisi di uno spot televisivo di cui vengono scansionati secondo per secondo l’attenzione, l’emozione e lo sforzo cognitivo spesi dallo spettatore di fronte alle immagini. Non vuol dire chiedere solo se quel video è “piaciuto”, bensì c’è la possibilità di capire davvero quanto sia arrivato al cuore delle persone. «In base ai risultati si può decidere di rimontare gli spot, ridurli da 30 a 15 secondi, creare messaggi adatti al pubblico femminile e altri in grado di cogliere l’interesse degli uomini», aggiunge il Ceo di Ottosunove. «E attenzione, questo vale anche per il mondo B2B: quante volte i decisori professionali “spengono il cervello”? Magari mentre cancellano un elenco sterminato di newsletter, o si trovano a dover scegliere tra due prodotti praticamente identici per prezzo e qualità…».
Tutti i dati vanno, dunque, interpretati e corretti, come insegna la scienza dei Big data. Per farlo bisogna fare ricorso agli attrezzi della psicologia e della sociologia comportamentale. Solo così si può spiegare perché una pubblicità è più efficace se il testimonial guarda il prodotto piuttosto che scrutare dritto negli occhi l’osservatore: i volti umani sono uno dei primi elementi su cui cade l’attenzione delle persone. Il risultato finale? Una sintesi perfetta di emozioni, ricordi, sensazioni e razionalità, cioè della nostra personalità e delle nostre esperienze passate. Perché è il nostro vissuto, insieme a ciò che siamo, a comporre la “percezione”, qualcosa tra l’istinto e la sensazione che determina gusti, preferenze, e quindi, acquisti. Anzi, secondo Gerald Zaltman, della Harvard Business School, il 95% delle nostre scelte viene compiuto a livello inconscio. L’esempio più lampante risale al 2004, quando un test mise di fronte Coca-Cola e Pepsi. Ebbene, le preferenze biologiche delle persone indicavano chiaramente il trionfo della Pepsi, ma non appena si rivelavano i nomi delle bevande gli intervistati affermavano nel 75% dei casi di aver maggiormente apprezzato la Coca-Cola. Potere dei brand e della pubblicità, ma il neuromarketing ha permesso di rivelare questa innocente bugia indotta. Perché la razionalità, in fondo, c’entra poco con le nostre scelte che avvengono spesso sotto la spinta delle emozioni.
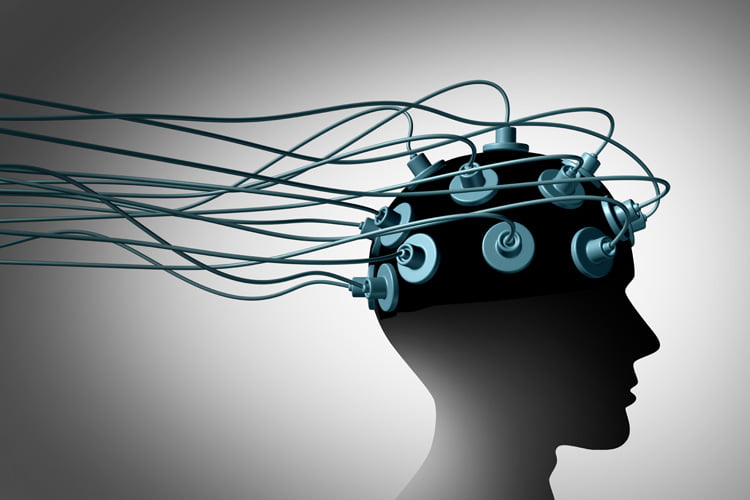
Partendo dagli studi di Martin Lindstrom, uno dei massimi esponenti di questa disciplina e autore di molte campagne di successo, possiamo affermare che una strategia vincente è quella che coinvolge i cinque sensi per migliorare l’engagement nei confronti del brand. Quando interagiamo con uno spazio – o un prodotto – si creano percezioni multi-sensoriali che parlano chiaramente dei gusti dei consumatori. Non stupitevi, perciò, se entrando in un fast food sentirete profumo di hamburger: non è buona cucina, ma il segno che stanno provando a “fregarvi” attraverso un aroma nei condotti di aerazione in nome del cosiddetto sensory branding (esiste veramente una bomboletta spray al profumo di cheeseburger al bacon). A “inventarlo” in un certo senso è stato lo psicologo Eric Spangenberg, che nel 2007 ha scoperto che diffondere profumo di vaniglia in un negozio di abbigliamento femminile faceva raddoppiare le vendite (lo stesso vale da Abercrombie & Fitch con quell’odore persistente). E non sono da meno le uova che trovate al supermercato: sono bianche in natura – avete presente la testa di Calimero? -, ma visto che il marroncino garantisce più serenità ai consumatori, gli allevatori ne hanno modificato il colore grazie a un’aggiunta di vitamine nell’alimentazione delle galline. Ma in alcuni campi non serve così tanto impegno per aumentare gli affari: basta dare un nome “etnico” a qualunque prodotto per dargli quel sound che spinge all’acquisto. Se non altro per curiosità. «Quante più aziende conosceranno i nostri bisogni e i nostri desideri inconsci, tanto più utili potranno essere i prodotti che potranno mettere sul mercato», scrive Lindstrom nell’introduzione del suo Neuromarketing (Apogeo).
Nel frattempo, le nuove tecnologie aprono ulteriormente la porta alla diffusione del neuromarketing. Oggi questo lavoro si fa sul web, di cui si può valutare l’efficacia tracciando il comportamento dei clic o il movimento degli occhi sulle varie aree di una pagina. Non a caso, nell’era della consulenza onnipresente, Facebook ha internalizzato il reparto di consumer insight, che fa anche neuromarketing. P&G e Unilever li hanno da anni senza aver bisogno di appoggiarsi agli istituti di ricerca: perché conoscere è potere e denaro. «Il web è uno dei territori più promettenti per la ricerca del neuromarketing. Non c’è bisogno di ricostruire la realtà, come nel caso dello studio dei comportamenti in una corsia di supermercato, quello che vedo sullo schermo se lo ritroverà davanti anche l’utente», spiega Florentino. «E poi da sempre in Rete si lavora sulla user experience, cioè sull’analisi “fredda” dei comportamenti delle persone attraverso l’analisi di miliardi di clic. Attraverso le nostre ricerche possiamo fare un passo in più: spiegare perché ci si concentra su una determinata porzione di pagina o perché alcuni contenuti ottengano più visualizzazioni rispetto ad altri. Queste evidenze ci permettono di costruire una comunicazione più efficace, quindi più redditizia per le aziende, ma anche più utile per tutti noi che veniamo quotidianamente bombardati da informazioni poco interessanti».
![]()
E il futuro? Domani toccherà, forse, alla realtà virtuale, da riprodurre attraverso i dati biometrici, in nome di una delle parole d’ordine dell’evoluzione tecnologica: immersività. Dopodomani potrebbe essere la volta del data mining, in grado quasi di trasformare il marketing in una nuova branca coinvolta dall’industria 4.0: attraverso lo sviluppo di speciali algoritmi di autoapprendimento, sarà possibile analizzare enormi quantità di dati ricavati dalle scansioni celebrali, moltiplicando le risposte alle domande del marketing. L’obiettivo, dunque, non è ingannare la mente dei consumatori con i cosiddetti brain tricks né provare a persuaderli con scorciatoie psicologiche. Il neuromarketing punta alla verità, alla scoperta dei veri meccanismi del cervello. E dell’anima.
© Riproduzione riservata






