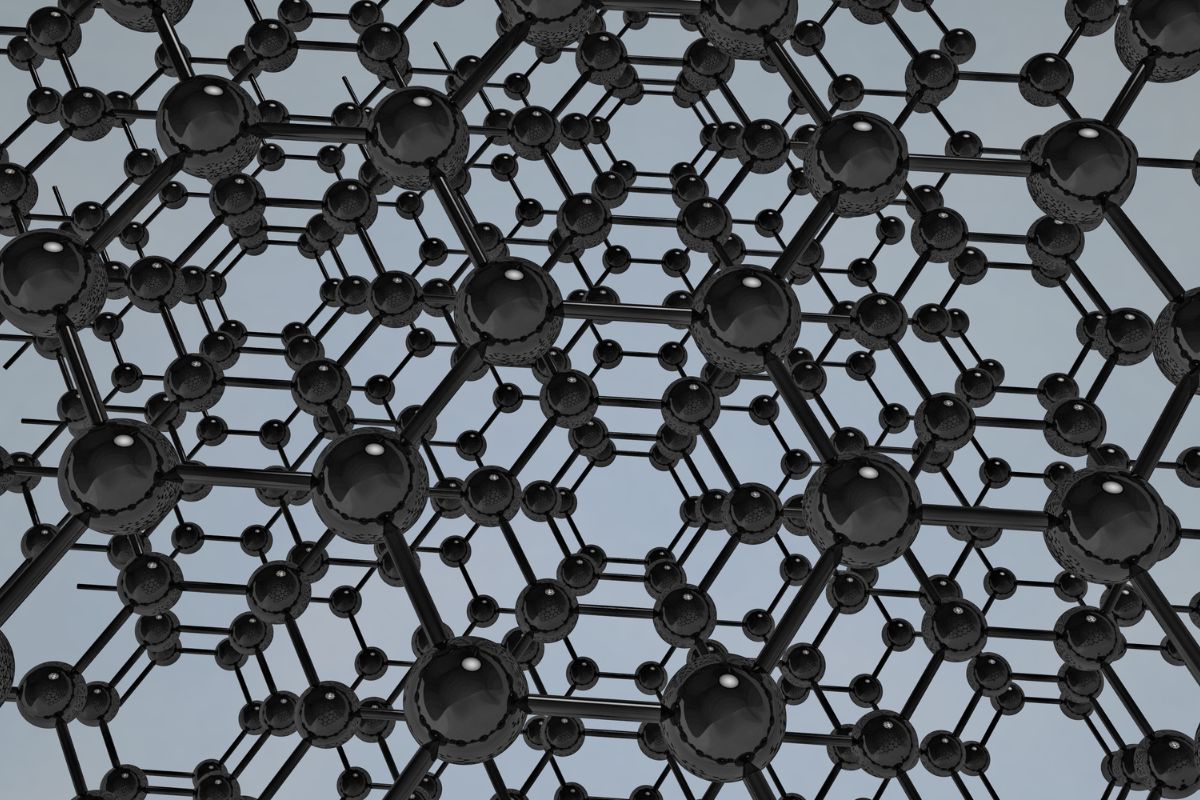Lo scorso ottobre si è tenuto a Bergamo il G7 dell’agricoltura e l’Italia si è presentata all’appuntamento da padrona di casa, e per una volta con la casa in ordine. Secondo i dati pubblicati dall’Eurostat lo scorso anno, l’Italia, con i suoi 52,9 miliardi di fatturato, è la seconda potenza agricola del Vecchio Continente, dietro alla Francia (70 miliardi) e davanti alla Germania (51,2 miliardi). Se si guarda invece al valore aggiunto, cioè a quanto i fattori di produzione (capitale e lavoro) fanno aumentare il valore di beni primari iniziali (come la terra) nel corso del processo di produzione e distribuzione, si vede che l’Italia, in ambito agricolo, con i suoi 30 miliardi di euro è il primo Paese dell’Ue. Questo, per esempio, dice l’Istat nel suo ultimo report dedicato all’economia agricola. Abbiamo anche un altro primato di cui andare fieri: siamo il Paese più “verde” d’Europa, come dimostrato dal numero impressionante di certificazioni alimentari: 291 specialità Dop/Igp e 451 vini Doc/Docg. Non bastasse, sul tavolo possiamo mettere anche le nostre 60 mila aziende biologiche e i nostri 4.965 prodotti alimentari censiti.
A dispetto di questi numeri, però, la situazione è tutt’altro che rosea e per capirlo basta chiedere agli operatori del settore se l’agricoltura italiana stia esprimendo tutto il suo potenziale. «Sicuramente no», risponde Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia. «Da 20 anni a questa parte l’innovazione vera non è più roba nostra. E non stiamo parlando solo di Ogm ma anche di ricerca genetica classica, sia nelle produzioni vegetali che zootecniche. Su queste ultime in particolare, paghiamo lo stato disastroso in cui versa la rappresentanza di settore degli allevatori e il fatto che abbia passato gli ultimi due decenni a difendere il monopolio nell’ambito della gestione degli albi genealogici di specie, perdendo di vista altre priorità, come l’introduzione in azienda di innovazione tecnica, gestionale e genetica. Tutto questo ci rende oggi del tutto dipendenti da quanto viene fatto all’estero». In parole povere, la nostra ricerca è ferma e quindi anche l’aumento della produttività diventa più difficile. Ci tocca usare semi e specie studiate per altre realtà, cercando quelle più adatte al nostro contesto.

La riflessione di Boselli apre la porta a un’altra considerazione: chi può fare ricerca, oggi? In ambito agricolo, infatti, sta avvenendo quello che gli economisti Robert Heilbroner e Lester Thurov descrivevano nel 1998 parlando di industria: la tendenza al gigantismo, come dimostra la recente acquisizione della Monsanto da parte della Bayer. È ovvio che un colosso del genere possa investire nella ricerca cifre impensabili per qualsiasi impresa agricola, per quanto grande, e noi, di aziende grandi, non ne abbiamo molte. Anche qui, un po’ di cifre possono dare un’idea. Per Eurostat, la loro dimensione media non supera 12 ettari (7,9 secondo Istat), mentre quelle francesi e tedesche si estendono mediamente su 57 ettari. In parte questo dipende dal fatto che è inferiore la nostra superficie agricola utilizzata (13 milioni di ettari contro i 27,7 e i 17 milioni di Francia e Germania), ma anche dal numero altissimo di aziende agricole. L’Istat nel 2010, anno dell’ultima indagine disponibile, ne ha censite un milione e 600 mila, 23.800 delle quali sprovviste di alcuna dimensione economica, mentre quella di 495 mila aziende non superava i 2 mila euro e quella di altre 500 mila aziende era compresa tra i due e i 4 mila euro. Di aziende agricole capaci di sfondare il tetto dei 100 mila euro se ne contavano appena 88.615.

Negli ultimi vent’anni, l’agricoltura italiana è cambiata molto. Sono morte centinaia di migliaia di aziende, alcune spinte fuori mercato dalla concorrenza straniera, altre perché chi le ha ereditate ha preferito vendere. Quelle rimaste sono diventate un po’ più grandi, ma non abbastanza. Con l’eccezione del settore vitivinicolo, in questo campo non sempre piccolo è bello. Non è un caso che siano le 397 mila aziende del Nord Italia, un quarto del totale e di dimensioni maggiori rispetto alla media, a fare il 52% del valore della nostra produzione. La tecnologia diventa essenziale per poter rilanciare un settore che per noi è strategico perché, connesso com’è all’industria agroalimentare, è una delle nostre eccellenze, uno dei nostri asset più importanti. Ma quale tecnologia? «Nel caso delle aziende più produttive», prevede Boselli, «l’orizzonte dei prossimi 30 anni diverrà quello delle colture fuori terra in ambiente controllato, aria compresa; questa sarà la vera frontiera dell’industrializzazione agricola. Già quella di oggi, comunque, è un’agricoltura di precisione, grazie alla gestione dei big data e all’utilizzo spinto delle tecnologie di geo-localizzazione». Il futuro è nelle tecnologie idroponiche e aeroponiche, che consentono di dare alle piante il nutrimento che trarrebbero dal terreno, ma senza l’impiego di quest’ultimo. Non si deve pensare che i prodotti così ottenuti siano scadenti, tutt’altro. Il problema, invece, è la standardizzazione del gusto.
Su questo e su altri cortocircuiti riflettono coloro che pensano che la tecnologia non sia una panacea e che prima di tutto bisognerebbe comprendere che l’agricoltura non è solo produzione di cibo. La pensa così Stefano Bocchi, ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee all’Università di Milano. «Fino a pochi anni fa, si guardava solo al dato produttivo, e c’era un motivo. L’Europa usciva dalla II Guerra mondiale con la paura della fame che – temevano gli Usa – avrebbe potuto creare instabilità, anche politica. Con il piano di aiuti, l’Italia era stata vista dagli Usa come un luogo molto importante dove rilanciare l’agricoltura in termini di produzione alimentare. L’unica parola d’ordine era aumento della produzione e della produttività, cioè della resa per ettaro. L’applicazione di questo modello, che Washington aveva già seguito, soprattutto nella fascia della Corn Belt, implicava che si investisse su alcune colture, i cereali in particolare, migliorandone la genetica e puntando sull’intensificazione agronomica, mirando cioè alla convergenza tecnologica». La tecnologia era l’elemento centrale e la produzione di cibo era l’unico scopo, e così è stato per decenni.
La svolta arrivò nel 2005 quando le Nazioni Unite, chiudendo un progetto di ricerca lanciato nel 2001, riconobbero all’agricoltura altre quattro funzioni, i cosiddetti “servizi ecosistemici”, che di fatto gli operatori agricoli avevano sempre svolto ma senza che venissero loro riconosciuti e potessero monetizzare quelle attività. In base a questo approccio, l’agricoltura non fornisce solo beni alimentari ma anche beni utilizzati da altre industrie; contribuisce alla regolazione dei cicli naturali come quello dell’acqua e della CO2 (non sono solo le piante a trattenere una quantità di anidride carbonica che non viene re-immessa nel sistema, ma anche la terra); ha una funzione culturale, difendendo e diffondendo un patrimonio di conoscenze, uno stile di vita più sostenibile. Infine, il lavoro del contadino è da sempre consistito anche nella difesa del territorio e nella cura di beni che servono alla collettività, mantenendo i terreni fertili e le acque pulite.
Naturalmente, spiegate così possono sembrare solo belle teorizzazioni e niente di più. Il professor Bocchi, però, sa tradurle in immagini e storie molto concrete. «Il Distretto agricolo della Valle dell’Olona, uno dei cinque distretti milanesi, ha firmato un accordo con la regione Lombardia in virtù del quale quest’ultima affida ai contadini la costruzione di vasche di laminazione, per controllare le esondazioni del fiume. La Regione ha scelto di investire un po’ di risorse per prevenire disastri anziché stanziarne molte a disastro avvenuto. Per i contadini è un reddito ulteriore». Quest’attività di controllo gli agricoltori l’avrebbero svolta comunque, perché su quelle terre hanno i loro prati, ma ora sono pagati per farlo. «Nei servizi ecosistemici si nasconde un tesoro. Per il futuro è importante che le aziende agricole smettano di specializzarsi in un solo prodotto o in una sola funzione e imparino a fornire contemporaneamente servizi diversi, senza dipendere solo dal mercato», spiega Bocchi.

Già, il mercato. Qui si nasconde un altro enorme problema per i nostri agricoltori. Dipendere solo da questo non conviene, anche perché così ci si espone alla concorrenza di Paesi in cui la manodopera è sottopagata e la legislazione ambientale è piuttosto blanda, come sanno bene i produttori di riso italiani, minacciati dall’invasione del riso cambogiano. Inoltre, dipendere dal mercato significa anche non contare molto. «Tra il contadino e il consumatore», ragiona Bocchi, «c’è una filiera molto lunga, composta da attori generalmente più grandi, dell’industria propriamente detta e della grande distribuzione, che sono poi quelli che fanno i prezzi e trattengono la fetta più grande del reddito prodotto. L’agricoltore non è abituato a decidere le proprie produzioni sulla base di quella che è la dinamica di mercato finale, cioè dei consumi, e per questo succede che c’è un biologico, con prezzi più alti, che ha una crescita a due cifre all’anno, e di contro una produzione ferma, per cui il grande distributore va a prendere all’estero prodotti che potrebbe trovare qui, come accade per il pomodoro, che importiamo dalla Cina. Il sistema agroalimentare è più lento di quello industriale, ed è ovvio, perché è la terra che ha i suoi ritmi, ma lavorando sulla de-intermediazione, cioè sulla riduzione della filiera, queste incongruenze si possono eliminare». Chi l’ha capito, ha trovato una scialuppa sicura. Fino a una ventina d’anni fa, nell’area di Abbiategrasso c’erano 25 allevamenti di vacche da latte, ora ne restano solo cinque. Molti sono stati fatti fuori dalla spietata concorrenza dei grandi produttori del Nord Europa, i cui governi hanno saputo disegnare una Pac (Politica agricola comunitaria), l’importante e ricca politica agricola comune, in base alle loro necessità. I cinque rimasti hanno smesso di fare solo latte e hanno cominciato a lavorare anche sui suoi derivati, ma soprattutto si sono rivolti al mercato locale, trovando un approdo nelle mense scolastiche della metropoli milanese. Qui c’è un attore, Milano Ristorazione, che con i suoi 85 mila pasti serviti al giorno è, di fatto, il più grande ristorante d’Europa ed è in grado di assorbire la loro produzione. Nei mercati locali, in cui si muovono attori pubblici o attori privati avvicinabili, produttori e consumatori si trovano a essere più vicini e a contare molto di più.
«Quando si parla di agricoltura», spiega il docente, «uno pensa al lavoro nei campi, sotto il sole, oppure in una stalla, mentre in realtà agricoltori e allevatori passano gran parte del loro tempo a riempire moduli». Questa è un altro dei controsensi generato dalla Pac. La de-burocratizzazione dovrebbe quindi essere un’altra via da percorrere. Per Bocchi, che ha appena pubblicato per il Touring Club un volume dedicato al rapporto tra città e campagna, il futuro della nostra agricoltura può essere brillante, purché non ci si fermi al dato tecnologico. «La nostra è anche un’agricoltura di paesaggi e di identità plurime, e questo deve essere il punto di partenza. Siamo il Paese delle cento agricolture e questo si riflette in una varietà paesaggistica ma anche ortofrutticola che è ciò di cui dobbiamo andare più fieri ed essere gelosi». Il futuro di questo settore, da noi, passa anche per la difesa del suo passato.
© Riproduzione riservata