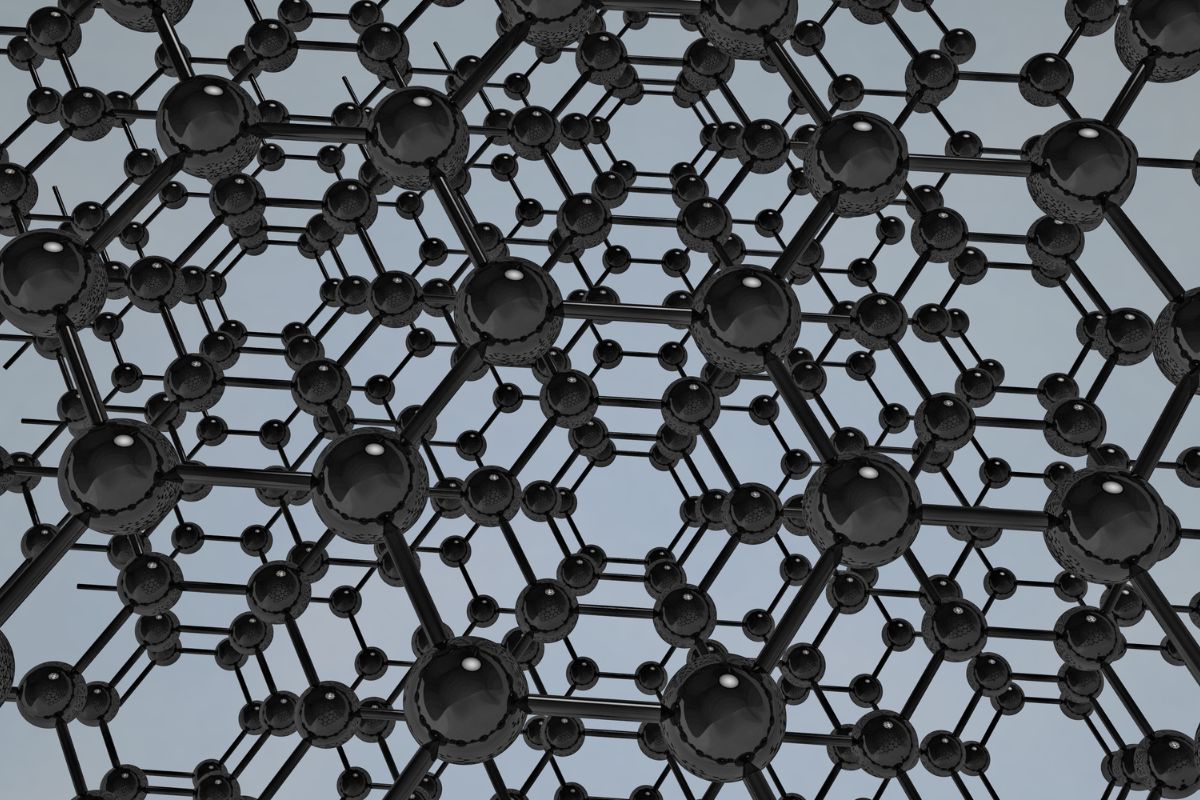Se le bollicine Gancia ora frizzano a Mosca, da quest’estate, invece, il gusto degli spumanti tedeschi Kessler, tipici della regione del Baden Württemberg, è stato addolcito dall’aggiunta di note tricolori: infatti, conquistandosi una quota di maggioranza, la cooperativa Cavit ha fatto il suo ingresso nel capitale del produttore tedesco. Una mossa strategica dal duplice obiettivo per il consorzio di Ravina (Tn), nato negli anni ’50 e che rappresenta il 60% della produzione vitivinicola regionale: incrementare il peso della propria presenza in territorio alemanno, ma anche valorizzare ulteriormente la produzione di uve Chardonnay dei propri soci italiani, impiegandole nel nuovo segmento. E forse non tutti sanno che in primavera, più o meno negli stessi giorni in cui vanti del Belpaese come Richard Ginori e Pomellato finivano nell’orbita di Kering, guidata da François-Henri Pinault, la merchant bank milanese di investimenti Tamburi Investments Partners rilevava il 20% di Roche Bobois, gruppo d’Oltralpe di mobili del lusso che vanta 335 negozi in 40 Paesi del mondo, con un giro d’affari di 530 milioni d’euro. Solo un paio di casi all’interno di una lista più lunga e articolata, tutta degna di nota, in controtendenza rispetto alla messa in vendita a gruppi internazionali del made in Italy. Perché, accanto a un’Italia preda di grandi multinazionali, ce n’è un’altra che non solo resiste, rimanendo ben ancorata sul territorio nazionale, ma persegue parallelamente anche una politica di importanti acquisizioni di marchi stranieri. Rafforzando la presenza Oltreconfine, incentivando la produzione, diversificando maggiormente l’offerta e talvolta migliorando persino il know how tecnologico e manageriale.
CAPITALI CORAGGIOSI Secondo le stime degli analisti di Kpmg, dal 2010 a oggi sono state condotte circa 230 acquisizioni italiane che hanno inglobato – parzialmente o completamente – diverse realtà estere, per un controvalore di circa 10,5 miliardi di euro. In testa alla classifica si collocano i cosiddetti “acquisitori seriali”, che anno dopo anno continuano a espandersi sui mercati stranieri rilevando rami d’aziende o intere imprese: ora per consolidarsi in aree dalle forti potenzialità commerciali, ora per avere una testa di ponte per entrare in territori ancora vergini. Qualche esempio? Si parte da big storici come Luxottica, apripista di queste politiche già nel 1999 con l’acquisto del marchio a stelle e strisce Ray Ban e, più recentemente, nel 2006, con quello di Oakley, brand sempre americano, leader mondiale del settore per il comparto sportivo. E poi ci sono Eni, che tra il 2011 e il 2012 si è rafforzata nei segmenti gas ed elettricità in Belgio e, nel primo settore, anche in Australia; Datalogic, leader globale nelle tecnologie di raccolte dati, che nel 2011 ha ampliato la propria presenza in Nord America conquistando il 100% di Accu-Sort, produttrice di sistemi di rilevazione automatica; Amplifon, che nel 2010 ha acquistato NHC, attiva nella commercializzazione di soluzioni per l’udito, potendo così entrare in India, Nuova Zelanda e Australia. Al vertice della top ten 2012 si è collocata la milanese Campari, che con un’operazione da circa 316 milioni di euro si è accaparrata l’81,4% nella società giamaicana Lascelles deMercado & Co. Dichiara in merito il Ceo del gruppo, Bob Kunze-Concewitz: «In questo modo consolidiamo ulteriormente la nostra massa critica nei mercati nordamericani, acquisiamo un posizionamento leader in un’importante destinazione turistica nei Caraibi, e creiamo le basi per una futura crescita internazionale sfruttando tutte le principali occasioni di consumo del rum, categoria in crescita, con particolare riferimento al segmento premium». Si tratta di una delle acquisizioni più rilevanti nella storia del colosso mondiale del beverage, fondato nel 1860 a Milano, insieme a quelle avvenute in precedenza delle distillerie statunitense Wild Turkey (nel 2009, per oltre 400 milioni di euro) e, prima ancora, di Skyy Vodka, sempre negli Usa (iniziata nel 2001/2002 e finalizzata nel 2006, per oltre 300 milioni di euro complessivamente). Da uno sguardo a un primo bilancio dell’anno in chiusura, invece, spicca Fincantieri, che ha acquisito il 50,75% della norvegese Stx Osv Holdings (455 milioni di euro), diventando così il quinto costruttore navale di riferimento su scala mondiale dietro quattro gruppi coreani. E figura anche Erg, che ha sottoscritto un accordo con la britannica International Power Consolidated Holdings Ltd per l’80% di IP Maestrale Investments Ltd, operatore di energie rinnovabili. Il deal, stimato in 860 milioni circa, consentirebbe alla compagnia genovese di diventare il primo operatore nazionale nell’eolico.
Destinazioni delle acquisizioni tricolori
ALLA CONQUISTA DI EUROPA OCCIDENTALE, USA E BRICSL’Europa occidentale resta la principale destinazione delle acquisizioni tricolori, con 36 accordi e un controvalore complessivo di 1,3 miliardi di euro nel 2012; Germania (9 acquisizioni), Regno Unito (8) e – a pari merito con tre deal ciascuno – Francia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi, sono stati, nell’ordine, i Paesi del Vecchio Continente che hanno maggiormente attirato investimenti italiani. Anche gli Stati Uniti si confermano un’altra delle mete strategiche privilegiate per gli investimenti tricolori; con 12 transazioni nel 2012 rispetto alle otto dell’anno precedente. Lo sa bene Interpump, produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione e uno dei principali player operanti sui mercati internazionali nel settore dell’oleodinamica. Il gruppo, fondato nel 1977 a S. Ilario d’Enza (Re) da Fulvio Montipò, tuttora presidente e amministratore delegato, con oltre 527 milioni di euro di fatturato, nel 2011 ha acquisito American Mobile Power per il prezzo di 6,8 milioni di dollari, andando così a rafforzare la propria posizione sul mercato statunitense e ad ampliare, diversificandola, la propria offerta commerciale.In questo quadro, calano lievemente le operazioni nell’area Brics (sei a fronte delle nove rilevate nel 2011). Tuttavia Cina, Brasile e Russia restano tra le priorità del prossimo biennio di Sorin Group, multinazionale leader a livello mondiale di dispositivi medicali per il trattamento delle patologie cardiovascolari fortemente radicata nel nostro Paese, con sede e stabilimento a Mirandola (Mo) e fabbriche anche a Saluggio (Vc). Interpellata da Business People, l’azienda dichiara che è su quei mercati che vi sono le maggiori opportunità di crescita, anche in considerazione degli indicatori macro-economici e demografici, dell’incremento della spesa sanitaria e degli investimenti in infrastrutture, oltre che per l’aumento dell’incidenza delle patologie cardiovascolari. Nella propria politica di espansione tramite acquisizioni estere, nel corso del 2012 il gruppo ha investito nell’americana Cardiosolutions e nelle francesi HighLife e Caisson nell’ambito delle procedure percutanee per la riparazione e sostituzione della valvola mitrale, mentre in quello della neurostimolazione per il trattamento dello scompenso cardiaco, sono stati realizzati investimenti nell’israeliana Enopace Biomedical e nella belga Neurotech. Negli anni, infine, si è distinta per numerose operazioni dirette verso l’estero anche Guala Closures, fondata nel 1954 ad Alessandria, diventata nel tempo leader mondiale nella produzione di chiusure di superalcolici, vino, alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. Tra i colpi più recenti messi a segno figura la divisione Metal Closures di Mcg Industries in Sud Africa. L’ingegner Paolo Ferrari, responsabile M&A del gruppo, così commenta: «Questa è stata l’ultima tappa, in ordine di tempo, di un percorso ben più lungo, iniziato anni fa con la nostra presenza prima in America Latina e in Asia (anni ‘90-primi del 2000), poi, a partire dal 2008-2009, in Australia e Nuova Zelanda, e successivamente nell’Est Europa. Iniziative che sono servite a presidiare direttamente quei mercati». Non senza alcune (piacevoli) sorprese: «Ricordo lo scetticismo, qui in Italia, quando abbiamo avviato produzioni in Paesi come la Colombia o, anni dopo, in Polonia e in Ucraina. Dubbi infondati: si è trattato, invece, di alcune delle strategie più profittevoli per il gruppo, avendo trovato in tali casi un management locale preparato e pronto a collaborare, tanto da permetterci una sostanziale crescita nelle dimensioni e nei ritorni economici di tali progetti».
Si scrive backshoring, si legge rilocalizzazione
«Servono più managerialità e risorse» Intervista a Max Fiani, Kpmg Corporate Finance |