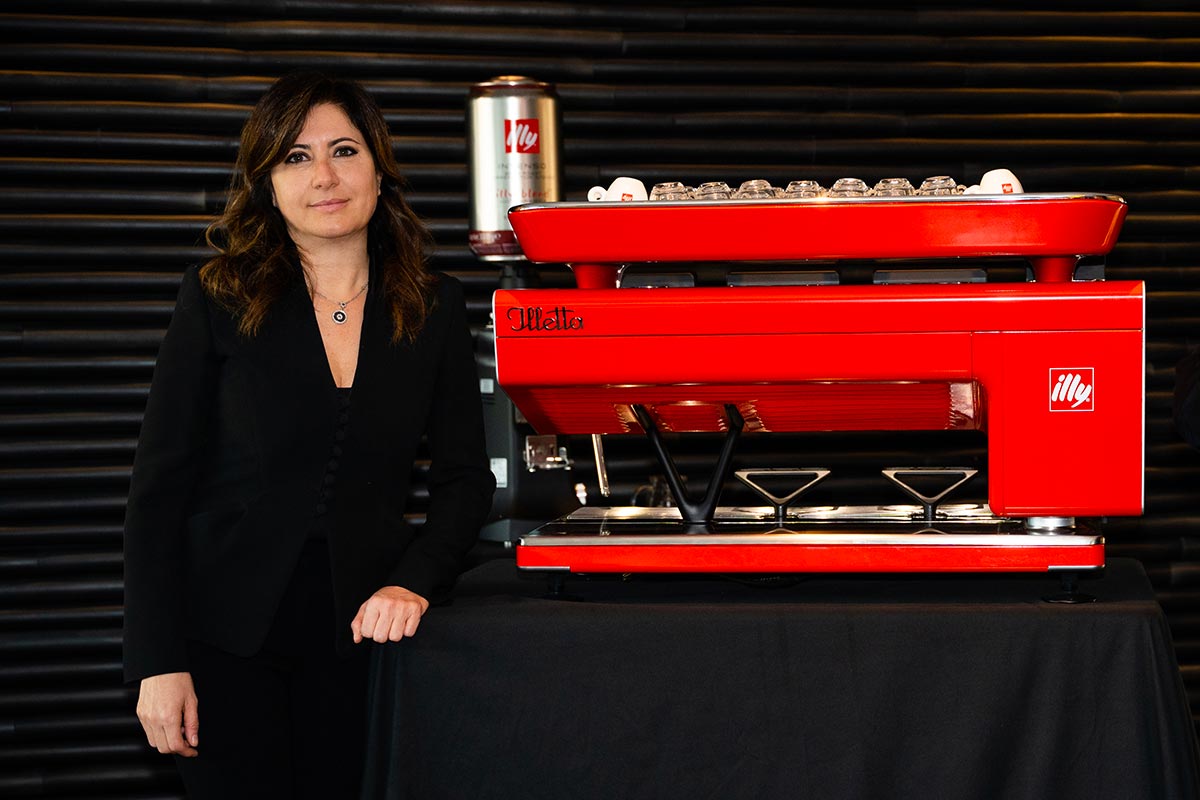Tira aria di tempesta sotto il piccolo cielo della finanza italiana. I primi boati, quelli che preannunciano la pioggia imminente, sono esplosi alla fine del 2008 e hanno riguardato le maggiori banche del Paese. La grandinata si è abbattuta per ultima anche su Intesa SanPaolo, dove Corrado Passera è riuscito nella sua (mai completamente spiegata) intenzione di eliminare uno degli uomini più importanti dell’istituto, Pietro Modiano, responsabile del 70% dei ricavi della banca. Inutilmente difeso dall’ala torinese della prima banca del Paese, Modiano è stato l’ultimo capro espiatorio di una crisi che ha fatto diverse vittime tra le quali anche numeri uno: Fabio Innocenzi del Banco Popolare, sostituito da Pier Francesco Saviotti, e Giampiero Auletta Armenise della Ubi Banca, sostituito dal direttore generale Victor Massiah. Si tratta in tutti i casi (volendo ci si può aggiungere anche quello di Guido Viola, direttore generale della Banca Popolare di Milano) di banche che non sono state travolte dall’onda anomala della crisi finanziaria, eppure la tempesta si è abbattuta ugualmente. In Intesa SanPaolo, Banco Popolare e Ubi Banca il 2009 sarà complicato perché occorrerà rodare i nuovi assetti e decidere se continuare nella politica della concessione del credito che le hanno caratterizzate nel 2008 oppure se è arrivato il momento di cambiare.
Il paracadute TremontiUn’indicazione sul clima che si respirerà sotto il piccolo cielo italiano lo si avrà quando il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, avrà scritto come, quando e per quale importo gli istituti italiani potranno accedere a quelli che (impropriamente) sono stati chiamati gli aiuti di Stato alle banche. Se ciò che è successo finora sembra una tempesta, quello che succederà allora potrebbe essere ben peggio. A provocare il cambiamento “di sistema” non saranno tanto le regole per accedere ai soldi pubblici da parte delle banche che si trovassero nella necessità di farlo, quanto le sanzioni per chi lo farà. Queste sono di due tipi. La prima sarà quella decretata dal mercato stesso. Chi emetterà delle obbligazioni con la copertura pubblica ammetterà implicitamente di essere una banca poco solida o, per lo meno, non così solida come si pensava ed è quindi logico che in Borsa e nel sistema degli scambi valutari tra istituti di credito verrà fortemente penalizzata. Ecco il motivo per cui nessuno si è azzardato a dichiarare esplicitamente di averne bisogno ed ecco perché, soprattutto, alcuni manager di primo piano hanno “volontariamente” deciso di farsi da parte. Se la loro ex banca dovesse ricorrere al paracadute statale, potranno sempre dire che non è stata colpa loro. Da notare che Intesa SanPaolo si è premurata di far sapere che la sua ultima emissione di obbligazioni non aveva alcuna garanzia pubblica e che, nonostante questo, è andata a ruba tra gli investitori istituzionali, anche stranieri.Il secondo tipo di sanzione è più immateriale ma altrettanto penalizzante. Tremonti ha dichiarato che i banchieri che hanno sbagliato devono andare “o a casa o in galera”. Ora: siccome molti manager sono già andati a casa, gli altri che “hanno sbagliato” dovrebbero, per forza di logica, andare in galera. Ovviamente non succederà (a meno della scoperta di clamorosi buchi nei bilanci dei quali per ora non si ha avvisaglia) e magari la dichiarazione di Tremonti è stata dettata da un temporaneo eccesso di veemenza retorica, ma resta il fatto che proprio i bond con la garanzia pubblica potrebbero essere il grimaldello con il quale il ministro più potente dell’esecutivo potrebbe essere indotto a regolare alcune partite ancora aperte e antipatie mai risolte. Basti dire che tra i grandi nomi della finanza italiana sono almeno due le banche che avrebbero urgente necessità di ricapitalizzarsi: Unicredit e Monte dei Paschi di Siena.
La variabile libicaMa la crisi finanziaria non è l’unica ad addensare nubi. C’è anche Gheddafi. Il leader libico, se terrà fede a tutte le dichiarazioni che ha fatto, è destinato a diventare quest’anno uno dei più importanti snodi della finanza italiana. Già ora il colonnello è presente con quasi il 5% nell’azionariato dell’Unicredit di Alessandro Profumo, costretto dalla mancanza di liquidi a varare un aumento di capitale da 6,6 miliardi di euro. In quella occasione sono entrati (non si sa quanto ben accetti dall’amministratore delegato) gli uomini di Gheddafi, i quali ora reclamano almeno una vicepresidenza. Ma è soprattutto quel 10% di Eni a fare la differenza. Se davvero la Libia dovesse diventare il secondo azionista della più importante azienda energetica italiana, allora qualsiasi mossa sullo scacchiere petrolifero mondiale sarebbe pesantemente condizionata dalla presenza di un Paese produttore nel capitale. Sarebbe ancora perfettamente libero l’Eni di proseguire i suoi disegni espansionistici in Russia, per esempio? E se i libici dovessero diventare soci anche della Telecom? Allora il cerchio sarebbe chiuso: grandi soci di una delle maggiori banche italiane, secondi azionisti (dopo lo Stato) dell’Eni e importanti azionisti anche della società telefonica nazionale. Finanza, industria e servizi. Sarà per questo che il ministro Tremonti non vede di buon occhio il loro massiccio impegno, che altri, invece, apprezzano come strumento per drenare liquidità nel sistema-Italia.Il match che si sta consumando sotto traccia su “libici sì” o “libici no” è più arroventato di quanto non si pensi. Il premier Silvio Berlusconi è il più acceso sostenitore delle ragioni del sì, anche perché rientrano all’interno di un accordo più ampio per i risarcimenti dei danni di guerra che lui stesso ha firmato a Tripoli con il colonnello. Tremonti non ci sta, invece, a dare in mano a fondi sovrani (sono gli strumenti finanziari che verrebbero usati) di un Paese non proprio democratico una così importante fetta della migliore imprenditoria italiana. D’altra parte, sostiene, dei soldi libici l’Italia può fare tranquillamente a meno. Non lo stesso le singole imprese e quindi, è il suo ragionamento, se qualcuna fosse nella necessità di ricapitalizzarsi e non trovasse i soldi può rivolgersi a Tripoli. A nome di Berlusconi, però.
Volti notiIn questo senso il 2009 sarà l’anno di chi ha i soldi in mano. E cioè i fondi di private equity, quelli sopravvissuti alla crisi, almeno. Tra quelli diretti da uomini della finanza italiani da due ci si attendono le mosse più importanti. Il primo si chiama Intermedia ed è stato fondato dall’ex numero uno dell’Unipol, Giovanni Consorte. Non è un vero e proprio fondo e l’acquisizione della banca monosportello Emilveneta è stata bloccata dalla Banca d’Italia (per questo il “banchiere rosso” si è dimesso da tutte le cariche rimanendo però socio), ma è dotata di grandi capitali (più di 150 milioni di euro) e soci danarosi (con i quali ha comprato Classica sim) perciò il 2009, con aziende a prezzi da saldo, potrebbe essere l’anno giusto per rilanciarsi. Il secondo è quello messo in piedi da un altro “banchiere rosso”, Vincenzo De Bustis che da Londra è a capo di Bridge e il cui braccio italiano, la Bn Finanziaria guidata dall’ex presidente delle Poste Enzo Cardi, ha già comprato la Banca Federiciana che dalla Puglia vuole allargarsi a tutt’Italia. Certo, il tempismo non è dei migliori, ma considerato che in Bridge è stato annunciato l’ingresso di capitali arabi, sostanziosi by definition, occorrerà tenerne d’occhio le mosse.Infine le assicurazioni. Cioè Generali. Nel 2009 inizieranno le grandi manovre per la sostituzione di Antoine Bernheim alla presidenza della maggiore compagnia italiana. E se ne vedranno delle belle, soprattutto perché non esiste al momento un successore designato. Fino alla sua plateale dichiarazione di rinuncia, Cesare Geronzi, presidente di Mediobanca, era l’unico a poter ambire a quella poltrona. Ma, a meno di colpi di scena, Geronzi, che resta comunque il vero vincitore della tempesta perfetta che si è scatenata nel mondo della finanza italiana, non salirà a Trieste. L’unico altro candidato con le carte in regola è Giovanni Bazoli, attualmente presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa SanPaolo, ma tutto fa pensare che il 2009 sarà il suo ultimo anno in servizio “permanente effettivo”. Sembra infatti che nessuno possa dissuaderlo dal suo proposito di approfittare della scadenza del suo mandato (in primavera) per tornare agli amatissimi libri nella sua città, Brescia. Così, almeno, possono essere interpretati gli articoli che il presidente ha scritto la scorsa estate sul Corriere della Sera nei quali parlava di sé e della sua esperienza di banchiere come una storia destinata a esaurirsi presto.Insomma, se nel frattempo non interverranno novità, come, ad esempio, un’operazione finanziaria insieme al competitor di sempre, la francese Axa, per la presidenza delle Generali sarà battaglia vera. Di quelle il cui esito decide il sistema di potere per gli anni a seguire.Uno degli elementi in campo nella vicenda delle Generali e dal quale non si può prescindere si chiama Romain Zaleski, l’industriale-finanziere di origini polacche che, partito con una dotazione superiore al 2% del capitale, detiene ancora una discreta quota del Leone. Attraverso la sua Carlo Tassara, super indebitata, in qualche modo parteciperà alla partita della successione di Bernheim, anche se in modo “passivo”. Per ottemperare agli accordi con le banche che lo hanno generosamente finanziato negli anni scorsi, Zaleski deve vendere praticamente tutti i suoi gioielli e tra questi il più brillante è proprio la quota detenuta nelle Generali che dovrà in buona parte essere dismessa, così come dovrà essere venduta anche la residua quota che detiene in Intesa SanPaolo. E colui che deciderà quando, a chi e a quanto vendere entrambi i pacchetti sarà proprio quel Pietro Modiano che ha dovuto fare le valigie dall’istituto di Passera. L’indebitamento della Tassara sarà un’ottima occasione per togliersi qualche sassolino, consumare certe piccole vendette, rientrare da protagonista nel gioco che conta. E partecipare al ridisegno delle nuvole sopra il piccolo cielo della finanza italiana.
© Riproduzione riservata